Il coraggio di prendere quel treno
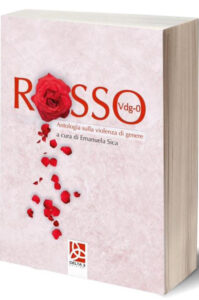 Quando, quella mattina, infilai in fretta poche cose in una borsa e a piedi raggiunsi la stazione della metro più vicina, neppure mi resi conto della svolta che stavo dando alla mia vita.
Quando, quella mattina, infilai in fretta poche cose in una borsa e a piedi raggiunsi la stazione della metro più vicina, neppure mi resi conto della svolta che stavo dando alla mia vita.
Non ero del tutto consapevole di essere in preda a una sorta di rivoluzione interiore, a seguito dell’incontrollato flusso di pensiero che mi dominava e che, per la prima volta, mi portava a credere di non essere io quella sbagliata.
Non so dire con precisione quando, ma fu in uno dei momenti insonni di quella lunga notte che decisi di approfittare di essere sola in casa, per mettere tutta la distanza possibile tra me e lui.
Un’opportunità capitata di rado in passato. Mai, però, prima di allora, l’avevo sfruttata anche solo per un caffè con un’amica, figurarsi arrivare a pensare di dileguarmi.
Il mio carceriere, che era partito per lavoro la sera prima, mi concedeva due giorni di tregua dal controllo maniacale che esercitava costantemente su di me, e io, non so come, avevo trovato il coraggio di agire in fretta.
Arrivata in stazione, salii di corsa su un treno semivuoto, le cui porte, con uno rapido scatto, si richiusero immediatamente dietro di me, come a impedirmi di ripensarci.
L’ora di punta era passata da un pezzo e, seduti a scacchiera, i pochi passeggeri della mia corsa mi sembrarono meno numerosi di quanto già non fossero. Presi posto in prossimità della porta, per lasciarmi la possibilità di scendere al volo qualora avessi voluto tornare indietro.
Mi sentivo osservata e, pertanto, ipotizzai che una metropolitana affollata mi avrebbe riparata meglio dallo sguardo di buona parte di quei viaggiatori, che simulava indifferenza, ma mi scrutava di sottecchi.
Quelle occhiate furtive, mi agitarono al punto, da condurmi sul baratro di un attacco di panico, che tentai disperatamente di arginare.
Mi scossi e per darmi un contegno e infondermi un po’ di coraggio, mi strinsi nel cappotto, cercando di restare calma. Sostenni senza sforzo apparente lo sguardo di un giovane che mi fissava, fino a quando non mi colse una stanchezza tale da fiaccarmi la volontà di resistere oltre.
A quel punto avvertii tutto il peso del bagaglio di vergogna, che ancora mi portavo dentro, e mi assalì il terrore che stesse per eclissarsi la fermezza che mi aveva fatto prendere quel treno.
La metro mi stava portando in un quartiere sconosciuto, all’indirizzo che poche ore prima mi avevano dato al numero 1522.
La RAI, con l’avvicinarsi del 25 novembre, lo faceva scorrere in sovrimpressione su tutti i programmi.
Io lo avevo memorizzato immediatamente, convinta tuttavia di non avere il coraggio di digitarlo.
E, mentre il treno continuava indifferente la sua corsa, senza più guardarmi intorno, immersa nel pensiero di quello che a breve avrei raccontato di me, riconquistai un certo equilibrio.
Il vagone mi cullava in un dondolio ipnotico, quando, il gracchiare dell’altoparlante, che annunciava la mia fermata, mi fece sobbalzare. Scesi riluttante, destabilizzata dalla domanda che, nel frattempo, si era insinuata nella mia mente: Che ci faccio qui?
La scacciai come si fa con un calabrone che ti vola vicino.
Restai ferma sul marciapiede della stazione a guardarmi intorno, per farmi un’idea di dove fossi.
E, tutto il grigiore, che quel quartiere di periferia non riusciva a mimetizzare sotto i grandi murales, dipinti sulle facciate dei caseggiati, fece inevitabilmente il paio con la desolazione che mi portavo dentro.
Quindi, senza più indecisioni, mi incamminai lungo lo stradone che avevo davanti e che, costellato di avvallamenti e buche, metteva in serio pericolo non solo i miei passi, ma anche la mia volontà di arrivare fino in fondo.
Dopo una gincana di un centinaio di metri, tra fossi, copertoni e rifiuti di ogni genere, scampata la frattura di tutte e due le caviglie, svoltai l’angolo e mi trovai di fronte il civico 105.
Il cartello sulla porta, grande abbastanza da poterlo leggere anche da una certa distanza, portava la scritta: “CENTRO ANTIVIOLENZA”.
Ero arrivata a destinazione.
Indugiai qualche attimo a osservare quella costruzione lunga e stretta, con grandi finestre allineate lungo tutto il suo perimetro.
Da poco avevano dato una mano di pittura giallo intenso alla facciata, e il colore la faceva spiccare sulle abitazioni grigie e scrostate in più punti che la circondavano, conferendogli anche una certa dignità.
Il vento di tramontana aveva liberato il cielo da una fitta foschia che, fino a poco prima, avvolgeva ogni cosa: splendeva un sole abbagliante, che però non scaldava.
Presa dallo spettacolo deprimente di quel quartiere, non mi resi conto che una giovane donna, forse la stessa che mi aveva dato istruzioni al telefono, era comparsa sulla porta e mi guardava con dolcezza.
L’idea che fosse riuscita a calcolare quasi al secondo il tempo che avrei impiegato per arrivare fin lì, mi diede la misura di quanta attenzione poneva verso chi le chiedeva aiuto.
Seduta nella stanza dei colloqui, affacciata su un piccolo giardino, aspettavo che lei ricomparisse da un momento all’altro.
La mia mente, intanto, partoriva parole senza un vero controllo, per poi incasellarle, come le tessere di un puzzle, nel racconto che mi preparavo a fare.
Cercavo di ricostruire la mia storia tenendo fede alla cronologia dei fatti, ma i ricordi seguivano un tempo tutto loro, che minava la possibilità di fare ordine dentro e fuori di me.
Mi proponevo, oltretutto, di essere più onesta possibile sulle ragioni del mio lungo silenzio, che però faticavo a motivare perfino con me stessa.
Negli ultimi otto anni avevo evitato di confidarmi con chicchessia e, d’altronde, con chi altri avrei potuto farlo, se tutti i miei parenti vivevano dall’altra parte dello Stivale?
Dalle amiche, invece, ci aveva pensato lui ad allontanarmi.
Avevo imparato presto a nascondere lividi e tumefazioni sotto i vestiti.
Nei meandri più bui della mia anima, invece, avevo relegato un dolore sordo, che avrebbe potuto sopraffarmi, se non mi fossi convinta che, quanto mi stava succedendo, altro non era che la logica conseguenza della mia inadeguatezza a essere una buona moglie.
Lui, che era diventato il mio aguzzino già dopo qualche settimana dal nostro matrimonio, era sempre stato attento a non lasciarmi ecchimosi sulle parti visibili del corpo, ma mi aveva segnata dentro in modo irrimediabile.
Ricordo che, quando ci eravamo conosciuti, ero rimasta folgorata dalla sua magnanimità, non sapendo che la sfoggiava per dissimulare una natura di soverchiatore, di cui credo fosse pienamente consapevole.
Come era cosciente di non avere empatia con i suoi simili e occultava sotto una meschina spavalderia l’incapacità di provare un sentimento vero verso chi diceva di amare.
Ero giunta perciò alla conclusione che, per conquistarmi, aveva recitato un ruolo preciso.
Era arrivato il momento di cercare le ragioni dell’orrore che avevo vissuto, ponendomi quelle domande che non avevo potuto o voluto farmi prima:
Mi perdonerò mai per essere diventata la sua schiava opportunista, la vittima che si coalizza col proprio carnefice?
Quand’era stata la prima volta che lo avevo giustificato, prendendomi ogni colpa e autorizzandolo a umiliarmi, picchiarmi, fino ad annientare ogni mia volontà?
Come avrei potuto capire subito con chi uscivo a cena, con chi facevo colazione la mattina, con chi andavo a letto ogni sera?
E, ancora, chi era l’infame maniaco con cui convivevo, il bambino cresciuto sempre in cerca di nuovi giocattoli, il ronfatore disfatto in cui si era trasformato colui che mi aveva accerchiato con gesti, parole, sorrisi, fino a convincermi che era il meglio che mi potesse capitare?
Ma ecco che la porta si apre con un leggero cigolio. Lei entra reggendo un vassoio con bricco e tazzine.
Si siede di fronte mi dice: mi racconterai la tua storia dopo il caffè.

